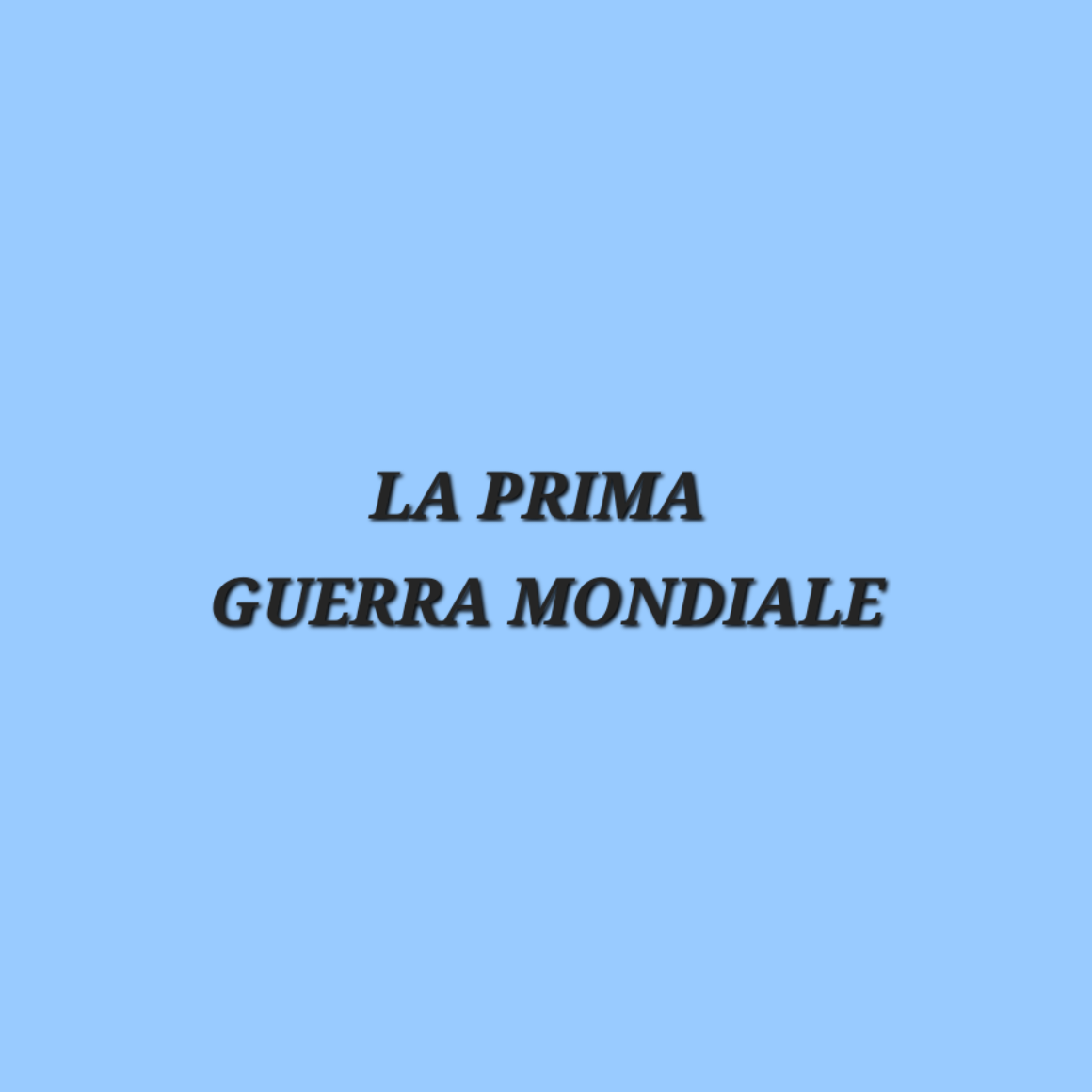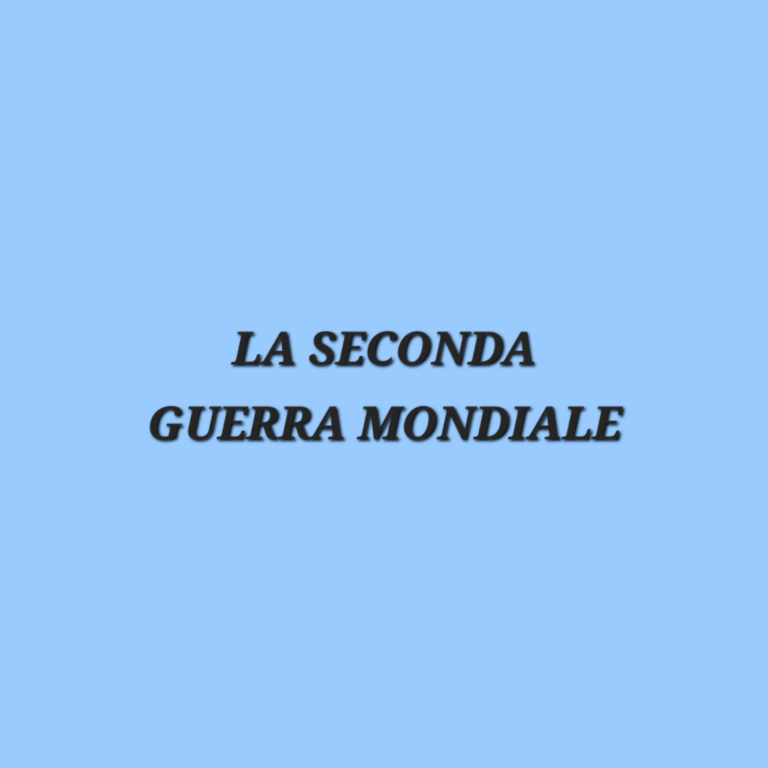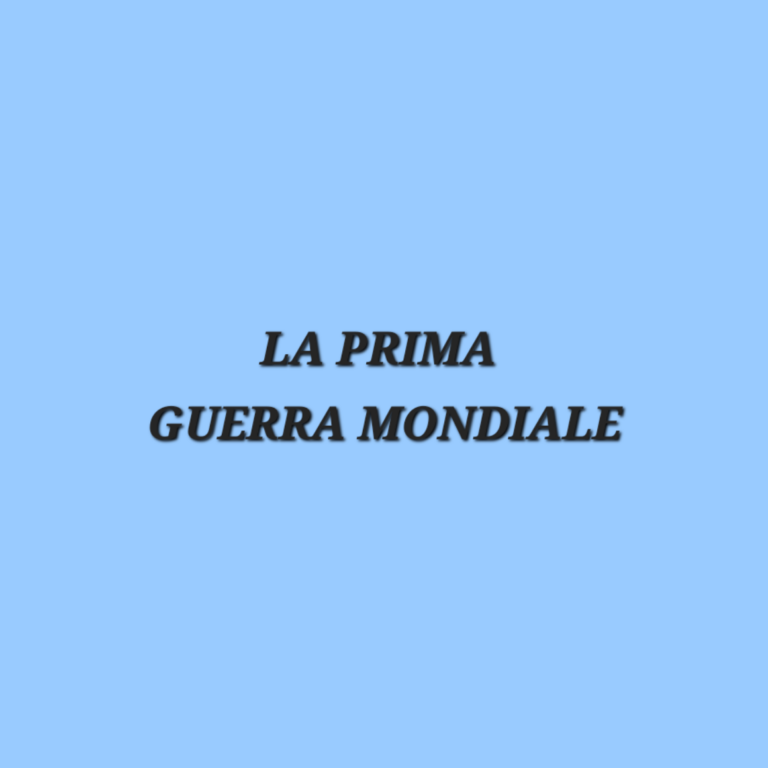IL MALATO DEL BOSFORO
IL MALATO DEL BOSFORO
Per tutto l’Ottocento le sorti dell’Impero ottomano sono al centro delle attenzioni delle potenze europee occidentali, preoccupate che la Russia non tragga eccessivo vantaggio dalla decadenza del “grande malato”: così nel 1820, al tempo della guerra per l’indipendenza greca, e ancora nel 1854, quando Francia e Gran Bretagna (e il Piemonte sabaudo) sono entrate in campo per appoggiare i turchi durante la guerra di Crimea.
Nel 1878 il congresso di Berlino, grazie alla mediazione di Bismark, vanifica i successi ottenuti sui campi di battaglia dalle armate dello zar, arrivate a pochi chilometri dal controllo degli Stretti. Nelle intenzioni occidentali, il congresso deve dare un equilibrio ai Balcani, rendendo indipendenti Romania, Serbia e Montenegro, ridimensionando il principato autonomo di Bulgaria (troppo filorusso), rafforzando l’Austria (in funzione antirussa) con il controllo della Bosnia-Erzegovina, affidando l’amministrazione dell’isola di Cipro alla Gran Bretagna. La soluzione irrita la Russia e non ferma la decadenza ottomana: nel 1896 Creta si ribella ai turchi e proclama successivamente l’unione alla Grecia.
Dopo il congresso di Berlino la Germania comincia inoltre a giocare pesantemente le sue carte nei confronti dell’Impero, sostituendosi alla Gran Bretagna nel ruolo di tutore: nel 1883 arriva a Istanbul la missione militare tedesca del generale Colmar von der Goltz; nel 1903 una società tedesca ottiene la concessione per una ferrovia che deve unire Konya a Baghdad e al Golfo persico.
Nel 1906 un gruppo di nazionalisti fonda il partito dei Giovani turchi, che si pone l’obiettivo di rinnovare l’Impero in senso democratico e unitario e di restituirgli piena indipendenza rispetto alle potenze occidentali.
Appoggiati dall’esercito, nel 1908 i Giovani turchi costringono il sultano Abdul-Hamid II ad abdicare e lo sostituiscono con l’inetto Maometto V. I progetti di riforma costituzionale sbandierati dai Giovani turchi resteranno tuttavia sulla carta, lasciando ben presto il posto a un rigido centralismo dello Stato e ad un esasperato nazionalismo in politica estera.
La lotta per le spoglie del dominio ottomano intanto continua: nel 1908 l’Austria annette la Bosnia-Erzegovina; fra il 1911 il 1912 l’Italia strappa all’Impero la Libia e le isole del Dodecaneso. In Medio Oriente l’Intesa si guarda bene dal favorire qualsiasi alterazione dello statu quo che possa mettere in pericolo il controllo sul Canale di Suez e sullo sbocco petrolifero dello Shatt-al-‘arab; ma nei Balcani la congiunta pressione russa e austriaca continua a provocare scosse. Nel 1912 la Lega balcanica (Serbia, Grecia, Bulgaria e Montenegro) strappa la Macedonia ai turchi, che perdono anche il controllo dell’Egeo.
Alla serie di sconfitte militari i Giovani turchi reagiscono alzando la bandiera del nazionalismo turco. All’idea del grande Impero multietnico sostituiscono quella dell’Impero anatolico fondato sull’etnia turca. Il governo guidato da Enver Pascià, generale in Libia nella guerra contro l’invasione italiana e poi ministro della guerra, cerca un nemico interno e lo trova nella minoranza armena, che pagherà a carissimo prezzo l’essere divenuta capro espiatorio per l’utopia panturca.
Enver cerca anche la riscossa militare e un alleato potente: lo trova nella Germania guglielmina. È il 1913 e a Istanbul arriva il generale Liman von Sanders al controllo di una missione militare tedesca con il compito di modernizzare e riformare l’esercito ottomano.