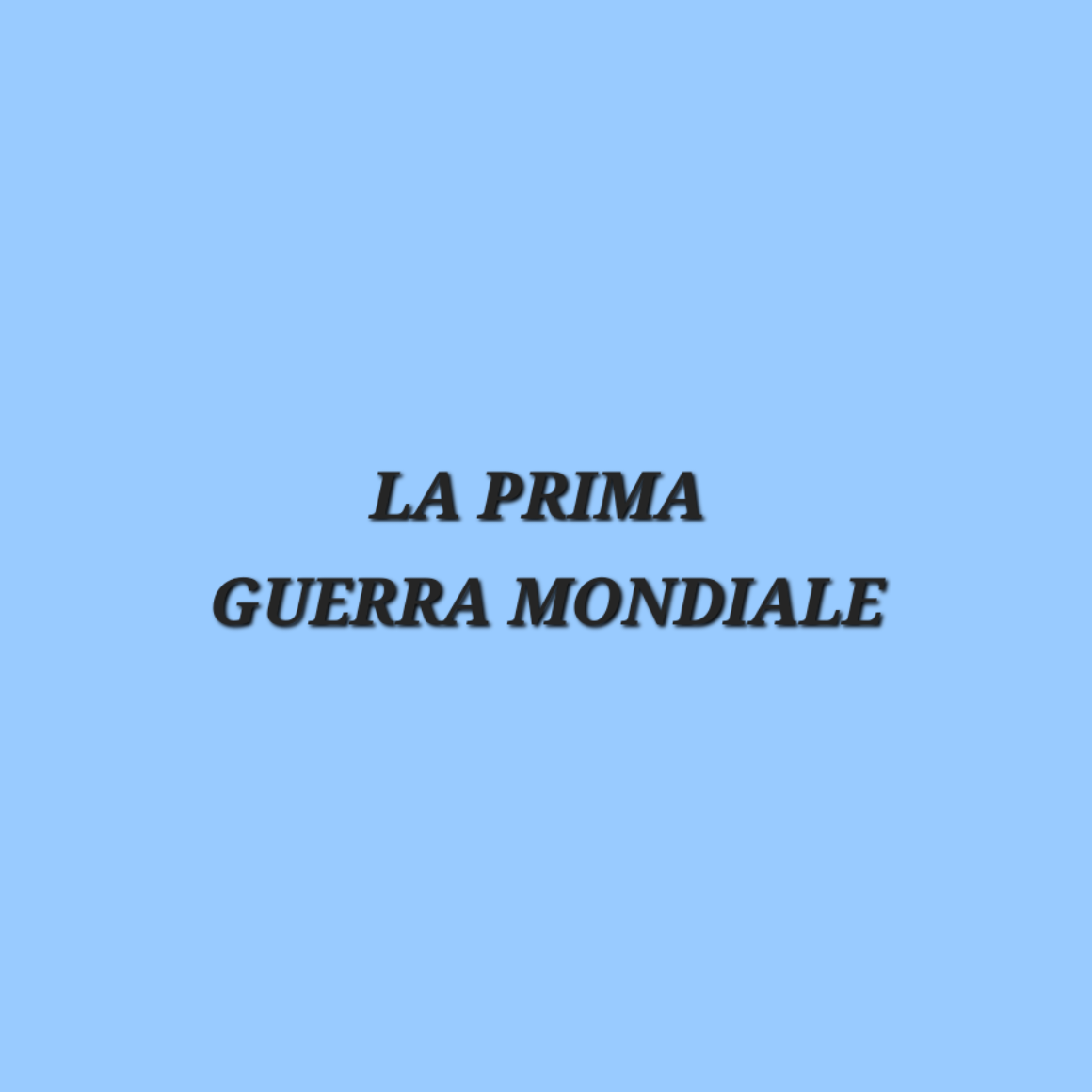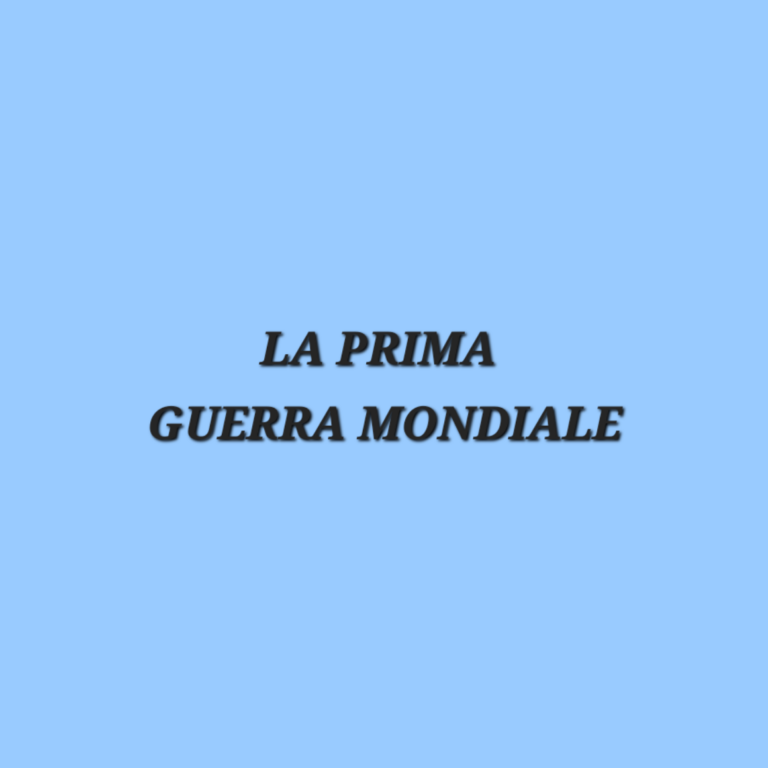LE CONTRADDIZIONI ITALIANE
LE CONTRADDIZIONI ITALIANE
L’Italia, che allo scoppio del conflitto europeo si dibatte nell’alternativa se intervenire o mantenersi neutrale, è uno Stato da poco costituito nel segno di un’unica sovranità e che aspira a essere annoverato tra le grandi potenze europee. Ma è anche un paese che resta per molti versi profondamente arretrato, soprattutto nel Meridione e nelle campagne. In effetti, pur tra molte contraddizioni, gli anni che separano l’unità dalla prima guerra mondiale rappresentano per l’Italia la genesi della società moderna. Il paese vive in questo periodo la prima vera rivoluzione industriale, cui si accompagnano l’organizzarsi delle classi lavoratrici e l’imporsi sulla scena politica delle forze popolari raccolte dal Partito socialista (fondato nel 1892) e dal movimento cattolico.
L’Ottocento ha visto compiersi l’unità italiana sotto l’egida dello Stato sabaudo. Dopo la presa di Roma nel 1870, restano ancora in mano austriaca il Trentino, la Venezia-Giulia e la Dalmazia. Nel 1876 la destra storica, che fino ad allora è stata alla guida del paese, è sostituita dalla sinistra, che governerà per venti anni. È un periodo molto travagliato per la vita politica e sociale italiana. La sinistra (ma i confini con la destra si fanno sempre meno netti) si dimostra incapace di esprimere effettivi programmi di governo e inaugurata la via del cosiddetto ‹‹trasformismo››, prassi che consiste nella ricerca del sostegno alle scelte governative non in una maggioranza parlamentare precostituita, ma in aggregazioni eterogenee che si costituiscono volta a volta attorno alle specifiche questioni. Nessuna concreta politica è diretta a sanare i grandi problemi sociali che affliggono il paese: il secolo si chiude con una grave crisi sociale e istituzionale e con un bilancio pieno di fallimenti e di contraddizioni. L’avvio dell’avventura coloniale, verso la quale i governi hanno tentato di indirizzare i sentimenti irredentisti e lo scontento popolare, ha portato a modeste acquisizioni nel Mar Rosso, ma è costato la cocente umiliazione di Adua (1896), quando il corpo di spedizione italiano è stato sbaragliato dall’esercito di Menelik e l’Italia si è vista costretta a riconoscere la sovranità dell’Etiopia.
Alla fine del secolo disordini sociali e tumulti per il pane scoppiano in tutto il paese. Dopo la repressione dei Fasci siciliani (1894), la cannonate del generale Bava Beccaris stroncano le agitazioni a Milano (maggio 1898). Seguono la legge marziale e lo scioglimento delle associazioni socialiste, radicali e cattoliche. Il 29 luglio 1900 a Monza i colpi di rivoltella dell’anarchico Bresci uccidono Umberto buono”, secondo la retorica monarchica, che tuttavia non aveva esitato ad avallare le azioni repressive.
Fra il 1903 e il 1912, tuttavia, la serie di governi guidati da Giovanni Giolitti normalizza il paese, avviando un processo di riforma in senso liberale, in sintonia con una rivoluzione industriale (soprattutto al Nord) sostenuta dal protezionismo economico. La neutralità governativa nei conflitti tra capitale e lavoro consente lo sviluppo dei sindacati. Si introducono il suffragio universale maschile e la statalizzazione dell’insegnamento elementare. Il principale obiettivo politico è l’assorbimento delle forze di opposizione socialiste e di quelle cattoliche, per la quali la ferita di Porta Pia non si è ancora rimarginata.
In politica estera, l’Italia è legata fin dal 1882 alla Triplice alleanza con Austri-Ungheria e Germania. Oltre al fascino per il modello prussiano, fatto di efficienza politica ed economica, alla gratitudine per i fatti del 1870 che hanno reso possibile la presa di Roma, sono stati i contrasti con la Francia – troppo attiva nello scacchiere Mediterraneo, con l’occupazione di Tunisi e troppo solerte nel contrastare qualsiasi interesse italiano nei Balcani – a spingere in tale direzione. Il trattato, di natura difensiva, permette all’Italia di alzare la voce sul terreno delle questioni coloniali e di partecipare alla spoliazione dell’Impero ottomano. Dopo l’occupazione francese della Tunisia (1881) e le due successive crisi marocchine (1905 e 1911), il governo italiano afferma nei confronti delle altre potenze un proprio diritto di intervento negli affari coloniali: nel 1911 si ha l’annessione della Libia, l’anno successivo l’occupazione di Rodi e del Dodecaneso.
L’entrata nella Triplice alleanza preclude tuttavia ogni possibilità di ridiscutere con l’Austria la situazione di Trento e di Trieste, per non parlare dei possibili sbocchi adriatici e balcanici. Anche se l’irredentismo agita solo una piccola (ma qualificata) parte dell’opinione italiana, la rinuncia alle due città resta una questione imbarazzante. Così nel 1914 il governo guidato dal conservatore Salandra decide per la neutralità: gli alleati non lo hanno consultato prima di presentare l’ultimatum alla Serbia e per di più si tratta di una guerra offensiva. La speranza è che l’Austria si convinca a comprare la neutralità italiana cedendo Trento e Trieste e forse qualcos’altro, ma la partita diplomatica è giocata in termini analoghi anche nei confronti dell’opposto schieramento belligerante.
Il dibattito sull’intervento si allarga rapidamente. Il fronte interventista è molto eterogeneo: dalla destra nazionalista (favorevole all’entrata in guerra a fianco della Germania ma, infuocata dalla retorica dannunziana, pronta a convertirsi alla guerra purché sia), ai repubblicani e ai socialisti riformisti (per i quali la guerra rappresenta il mezzo per liberare i popoli ancora soggetti all’Austria), ai liberali conservatori (a loro volta convinti che l’intervento debba portare a compimento l’esperienza risorgimentale; si riconoscono nel “Corriere della Sera” di Luigi Albertini, e hanno un loro esponente nel ministro degli esteri Sidney Sonnino), a una parte della grande industria.
Non meno composito il fronte neutralista: giolittiani (convinti che al tavolo della pace l’Italia potrà ottenere “parecchio” e senza sangue), cattolici (preoccupati di ripercussioni contro la Santa Sede, dell’alleanza con le democrazie liberali, della possibile dissoluzione della cattolica Austria e di un aumento dell’influenza ortodossa nei Balcani), socialisti (fedeli alle posizioni pacifiste dell’Internazionale), gruppi industriali esportatori come la FIAT di Torino.
Intanto l’Austria-Ungheria non ha intenzione di trattare, e la guerra comincia, senza l’Italia.