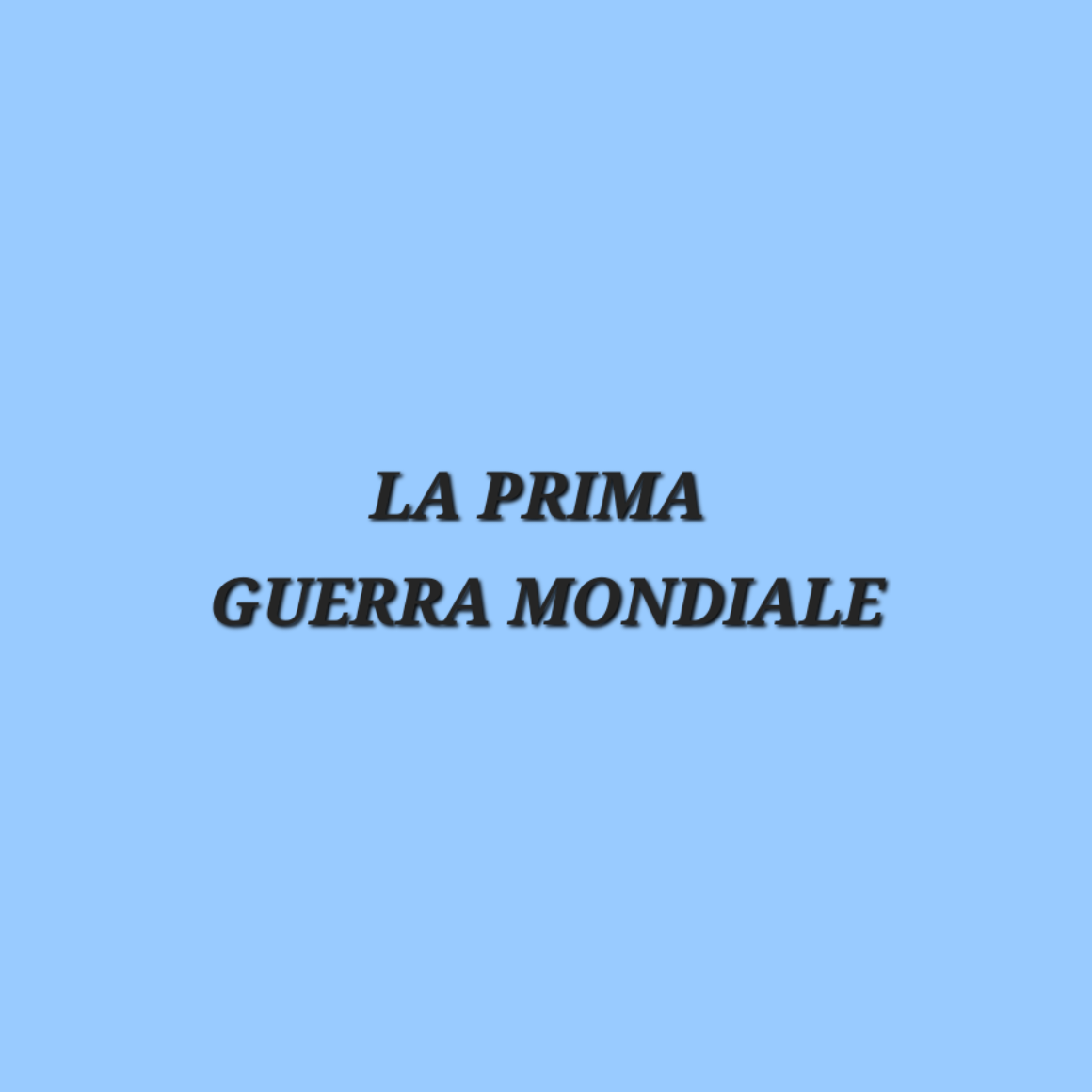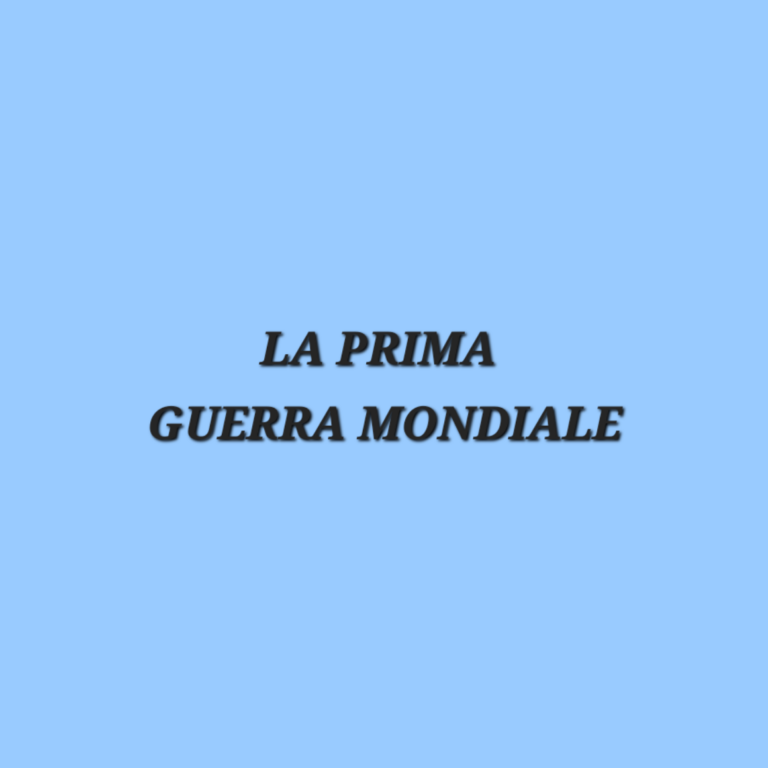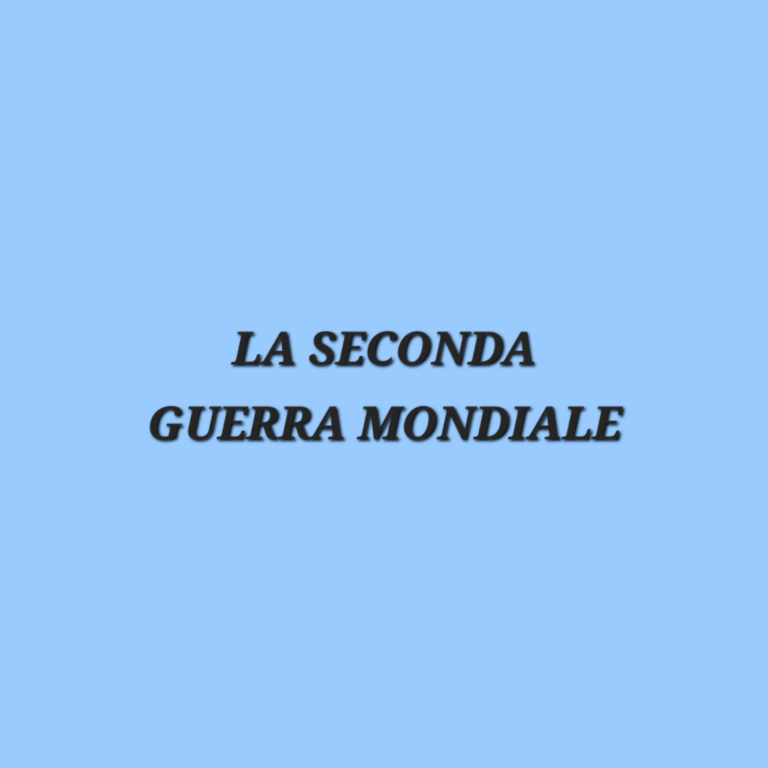LE CONTRADDIZIONI ITALIANE
LE CONTRADDIZIONI ITALIANE
L’Italia, che allo scoppio del conflitto europeo si dibatte nell’alternativa se intervenire o mantenersi neutrale, è uno Stato da poco costituito nel segno di un’unica sovranità e che aspira a essere annoverato tra le grandi potenze europee. Ma è anche un paese che resta per molti versi profondamente arretrato, soprattutto nel Meridione e nelle campagne. In effetti, pur tra molte contraddizioni, gli anni che separano l’unità dalla prima guerra mondiale rappresentano per l’Italia la genesi della società moderna. Il paese vive in questo periodo la prima vera rivoluzione industriale, cui si accompagnano l’organizzarsi delle classi lavoratrici e l’imporsi sulla scena politica delle forze popolari raccolte dal Partito socialista (fondato nel 1892) e dal movimento cattolico.
L’Ottocento ha visto compiersi l’unità italiana sotto l’egida dello Stato sabaudo. Dopo la presa di Roma nel 1870, restano ancora in mano austriaca il Trentino, la Venezia-Giulia e la Dalmazia. Nel 1876 la destra storica, che fino ad allora è stata alla guida del paese, è sostituita dalla sinistra, che governerà per venti anni. È un periodo molto travagliato per la vita politica e sociale italiana. La sinistra (ma i confini con la destra si fanno sempre meno netti) si dimostra incapace di esprimere effettivi programmi di governo e inaugurata la via del cosiddetto ‹‹trasformismo››, prassi che consiste nella ricerca del sostegno alle scelte governative non in una maggioranza parlamentare precostituita, ma in aggregazioni eterogenee che si costituiscono volta a volta attorno alle specifiche questioni. Nessuna concreta politica è diretta a sanare i grandi problemi sociali che affliggono il paese: il secolo si chiude con una grave crisi sociale e istituzionale e con un bilancio pieno di fallimenti e di contraddizioni. L’avvio dell’avventura coloniale, verso la quale i governi hanno tentato di indirizzare i sentimenti irredentisti e lo scontento popolare, ha portato a modeste acquisizioni nel Mar Rosso, ma è costato la cocente umiliazione di Adua (1896), quando il corpo di spedizione italiano è stato sbaragliato dall’esercito di Menelik e l’Italia si è vista costretta a riconoscere la sovranità dell’Etiopia.
Alla fine del secolo disordini sociali e tumulti per il pane scoppiano in tutto il paese. Dopo la repressione dei Fasci siciliani (1894), la cannonate del generale Bava Beccaris stroncano le agitazioni a Milano (maggio 1898). Seguono la legge marziale e lo scioglimento delle associazioni socialiste, radicali e cattoliche. Il 29 luglio 1900 a Monza i colpi di rivoltella dell’anarchico Bresci uccidono Umberto buono”, secondo la retorica monarchica, che tuttavia non aveva esitato ad avallare le azioni repressive.