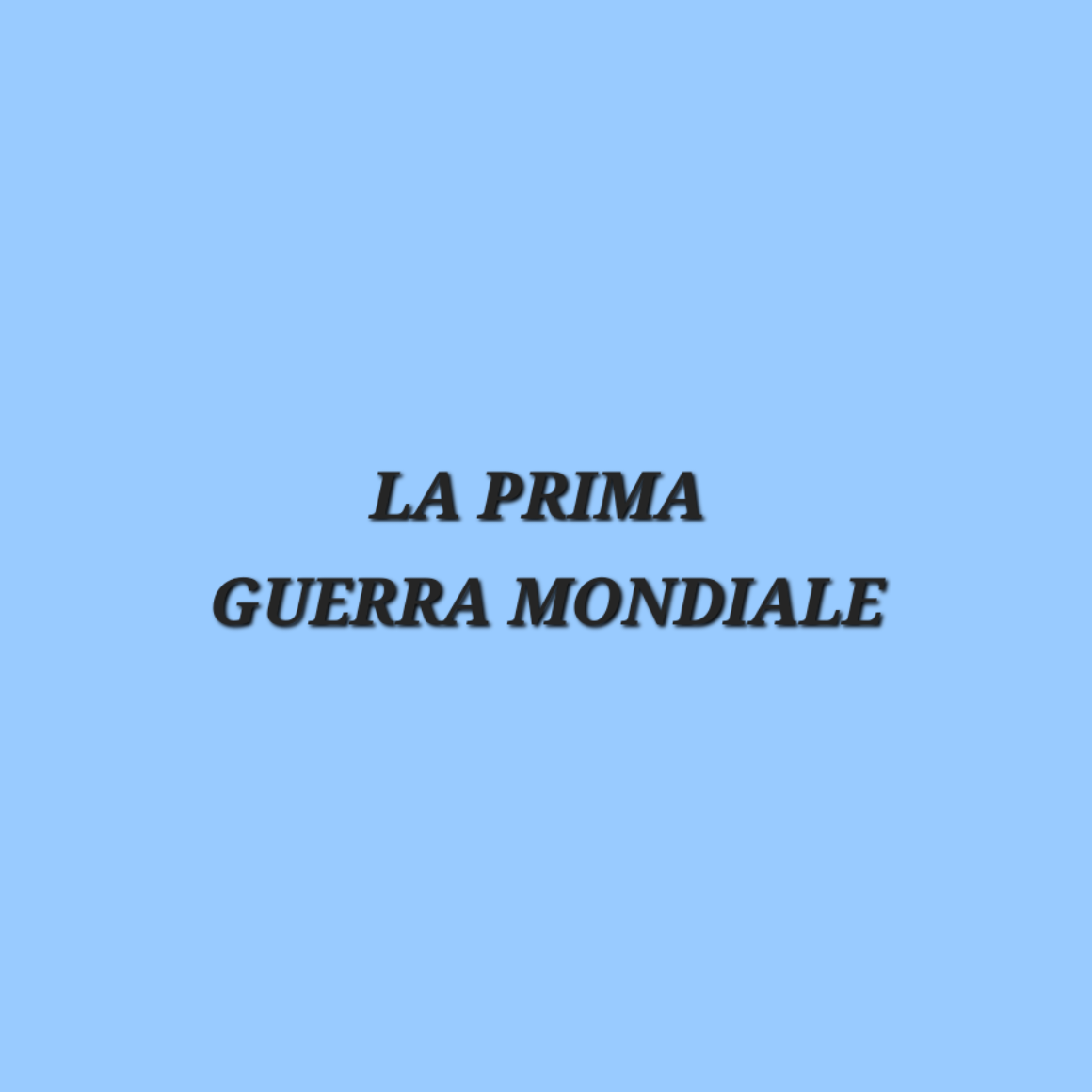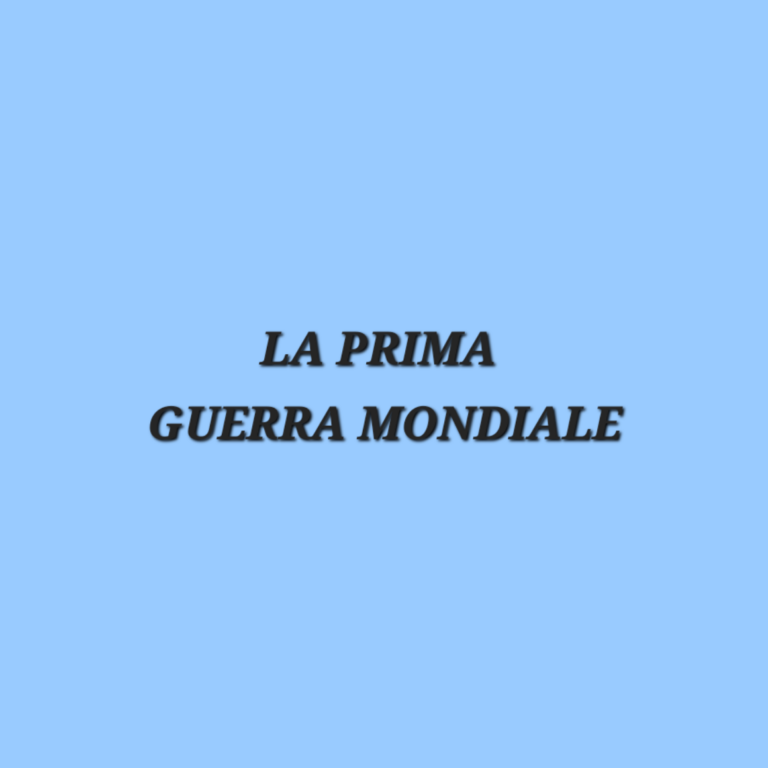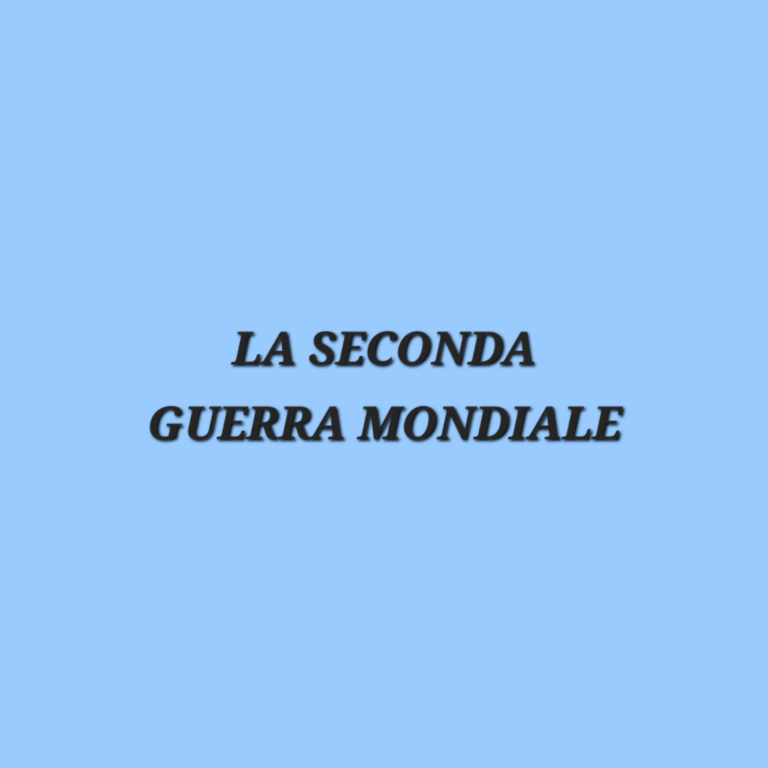L’AUTOCRAZIA DEI ROMANOV
L’AUTOCRAZIA DEI ROMANOV
All’apertura del XX secolo lo sterminato e multinazionale Impero russo, per quanto alleato delle due maggiori potenze progressiste, la Francia e la Gran Bretagna, è ben lontano dall’Europa liberale.
Il regime degli zar (appannaggio della dinastia Romanov dal 1613) è autocratico, sostenuto dalla più cruda repressione di ogni forma di opposizione interna. Alle persecuzioni religiose e all’imposizione della lingua e cultura russe a tutti i sudditi, che già hanno caratterizzato il regno di Alessandro III (1881-1894), si è aggiunta la repressione poliziesca esercitata contro l’emergente manifestazione di tendenze liberali da parte della borghesia e le espressioni di insoddisfazione provenienti delle masse contadine condannate all’indigenza. Per convogliare il malcontento popolare, sotto gli zar si favorisce l’antisemitismo, e le esplosioni dei pogrom contro i quartieri ebraici insanguinano il paese.
Sebbene la grande maggioranza della popolazione dell’Impero resti agricola, lo sviluppo industriale che si è registrato a partire dalle ultime decadi dell’Ottocento ha indotto profondi mutamenti nel volto sociale di alcune aree del paese. La formazione di un proletariato industriale, scarsamente retribuito e concentrato nelle città, agevola la diffusione delle idee anarchiche e delle dottrine socialiste. Nel 1898 nasce il marxista partito operaio socialdemocratico russo. Gli aderenti sono perseguitati dal regime, e i leader, tra cui Lenin, costretti in carcere o in esilio, da dove comunque seguitano a mantenere i legami con la patria e a organizzare il dissenso. E in esilio, a Londra, si tiene nel 1903 il secondo congresso del partito, che nell’occasione si scinde in due correnti: la maggioritaria o “bolscevica” sotto la direzione di Lenin, sostenitrice di una concezione del partito quale avanguardia politica di rivoluzionari di professione col compito di guidare le masse verso la conquista del potere; e la minoritaria o “menscevica”, orientata verso un’idea più aperta dell’organizzazione, quale grande movimento di massa, e per un programma più graduale di intervento.
Sotto Nicola II (1894-1917) la situazione della Russia si fa critica. Allo scoppiare di scioperi e rivolte si risponde con metodi repressivi sempre più duri, ma questo non fa che inasprire le contraddizioni sociali interne al paese e destabilizzare il regime.
Nel 1905 è una guerra a far traballare lo Stato autocratico dello zar. Le sconfitte subite dall’esercito e dalla flotta russa a Mukden, a Port Arthur e a Tsushima nel conflitto contro il Giappone, ai remoti confini orientali dell’immenso dominio dello zar, sono l’occasione per una breve stagione di sommosse popolari che dilagano in tutto l’Impero. In esse si confondono le aspirazioni della borghesia liberale in cerca di un ruolo politico, le ambizioni rivoluzionarie della frazione bolscevica del partito socialdemocratico, le richieste di operai e contadini per un miglioramento delle condizioni di vita.
La prima rivoluzione russa si apre con la strage a opera della guardia imperiale dei manifestanti di un corteo pacifico diretto al “Palazzo d’inverno”, la residenza dello zar a San Pietroburgo, e vive l’episodio dell’ammutinamento dell’incrociatore Potëmkin a Odessa, immortalato dal genio del regista sovietico Sergej M. Eisenstein.
Nell’ottobre del medesimo anno Nicola II deve concedere il rispetto delle libertà fondamentali e l’istituzione di un parlamento elettivo (Duma), una mossa che spezza la fragile alleanza fra liberali e rivoluzionari e approfondisce il solco fra bolscevichi e menscevichi. In dicembre una serie di nuove insurrezioni armate dei consigli operai (soviet) è repressa nel sangue a Mosca, a Rostov, a Batum, dimostrando come non esistano ancora le premesse rivoluzionarie attese da Lenin, e soprattutto come il malcontento di larga parte del paese abbia radici e obiettivi essenzialmente economici e non sia indice di volontà rivoluzionaria.
Così l’esperimento di vita democratica della Duma si avvia al fallimento. fra il 1905 e il 1907 lo zar può sciogliere due parlamenti poco docili prima di ottenere una terza Duma, espressione del blocco conservatore. Contemporaneamente il primo ministro Stolypin avvia il più serio tentativo di salvare la monarchia. Una profonda riforma agraria dovrà dissolvere le strutture secolari della campagna russa fondata sulla proprietà collettiva (mir), dando vita a una classe di contadini-proprietari interessati alla salvaguardia del regime; la massa di contadini proletarizzati verrà invece assorbita dalle sempre crescenti esigenze dell’industria, in un sistema che si è aperto recentemente alla penetrazione del capitalismo straniero. Due le condizioni necessarie al piano di Stolypin. La prima è l’ordine interno, e una capillare quanto spietata opera di repressione percorre il paese, imponendo un regime di terrore. La seconda è il tempo, almeno dieci anni di lavoro.
Né l’una né l’altra condizione si verificheranno: il 14 dicembre 1911, all’Opera di Kiev, due colpi di pistola esplosi dal socialista rivoluzionario Bagrov eliminano l’uomo più temibile a disposizione della monarchia. Tre anni dopo, la risposta russa alla dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia è la mobilitazione generale. ‹‹Se la guerra riesce per noi vittoriosa, si potrà ottenere senza fatica di tenere a freno il movimento socialista… Ma in caso di sconfitta non si potrà evitare da noi la rivoluzione sociale nei suoi aspetti più estremi››. Così si esprime nel 1914 il ministro degli interni Durnovo, a cui lo zar ha richiesto un parere sull’eventualità di un conflitto: l’avventura bellica sarà fatale per la Russia zarista.