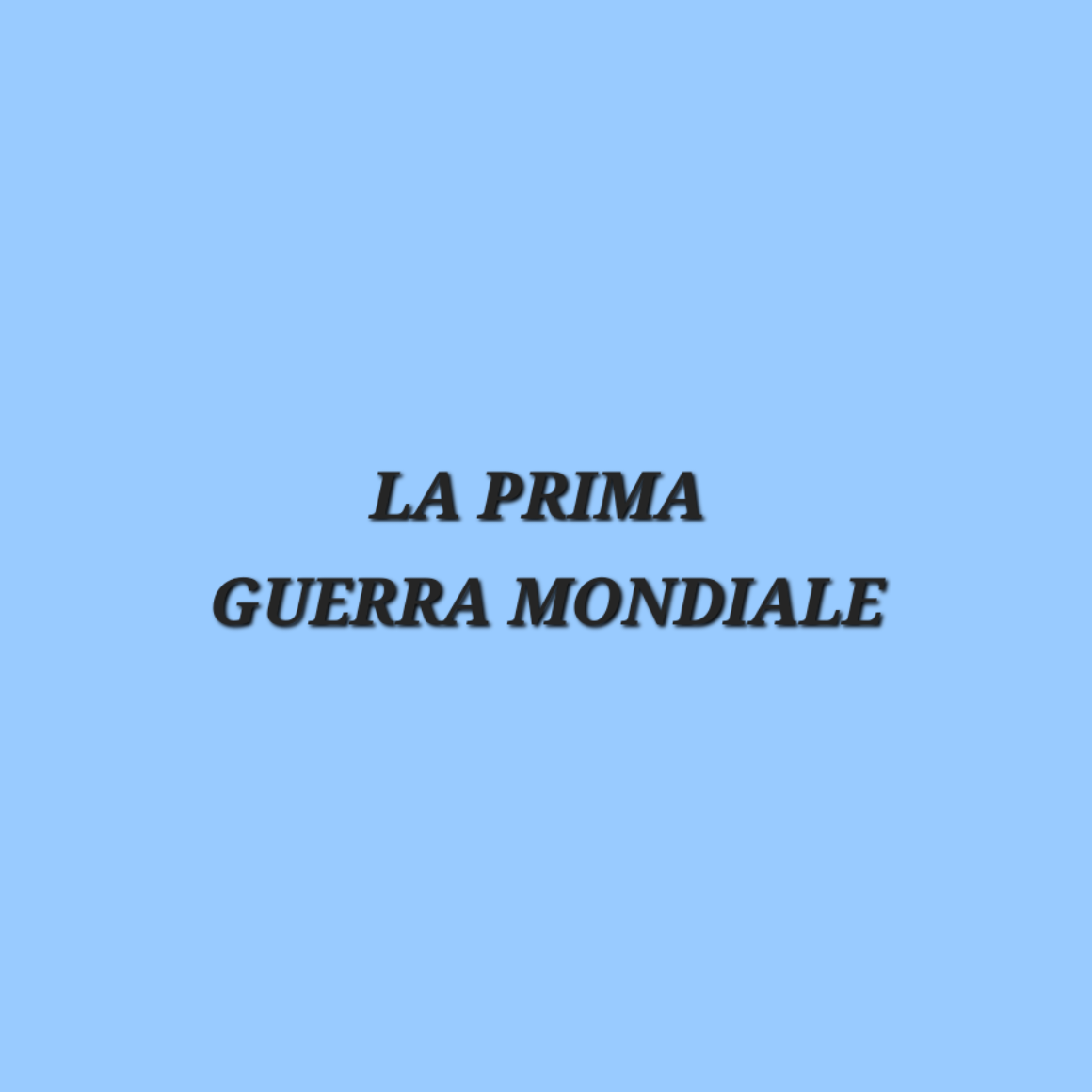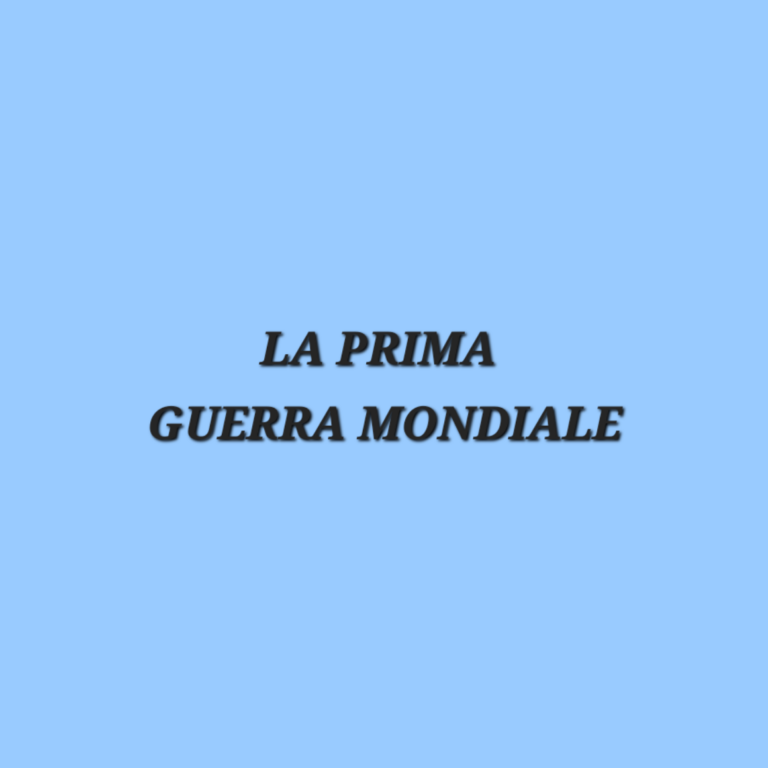IL SOGNO DI UNA GRANDE GERMANIA
IL SOGNO DI UNA GRANDE GERMANIA
La Germania che si lancia nell’avventura bellica nel 1914 è uno Stato giovane, potente e aggressivo. È al 1871 che risale infatti l’unificazione dei singoli Stati tedeschi in un Impero a carattere federativo (Reich) con a capo il re di Prussia, assurto al ruolo di imperatore (Kaiser).
Nei primi venti anni l’Impero è guidato dall’artefice dell’unificazione e della vittoria sulla Francia nel 1870, con la conseguente annessione dell’Alsazia-Lorena: il cancelliere Otto von Bismarck. Tesa al rafforzamento dello Stato appena creato, la politica di Bismarck si appoggia alle forze della destra, sostanziandosi in un energetico programma di accentramento condotto attraverso una lunga e, in ultima istanza, vana lotta contro l’autonomismo cattolico e contro l’affermarsi del nuovo partito socialdemocratico, mentre il consenso presso l’opinione pubblica è ricercato mediante il varo di un ardito piano di riforme sociali. In politica estera Bismarck persegue due obiettivi: garantire la sicurezza dello Stato, in particolare con l’isolamento della Francia animata dall’aspirazione alla rivincita, e presentate all’Europa un Impero rapidamente consolidato come grande potenza militare e industriale. Il congresso di Berlino del 1878, in chiusura dell’ennesima guerra russo-turca, sancisce il ruolo internazionale del Reich che, con la mediazione messa in atto a favore degli sconfitti e nel gioco della spartizione dei territori balcanici, si conquista la riconoscenza di Vienna e di Istanbul. Nel 1882 viene siglata la Triplice alleanza che lega la Germania all’Austria e all’Italia; nel 1887, con il trattato di “controassicurazione” stipulato con la Russia, le due potenze si garantiscono la reciproca neutralità in caso di conflitto.
Il complesso sistema di rapporti internazionali creato dalla diplomazia di Bismarck è destinato però a sgretolarsi rapidamente dopo l’ascesa al trono di Guglielmo II nel 1888. Non ancora trentenne, di temperamento risoluto e impulsivo, il nuovo imperatore si fa interprete delle aspirazioni imperialiste che si vanno affermando in ambienti intellettuali e tra gli ufficiali dell’esercito. Prende forma l’idea del dominio sull’intera Europa centrale: una Grande Germania, che dovrebbe riunire tutti i popoli di lingua tedesca considerati, sulla base della teoria darwiniana, l’espressione più pura della superiore razza ariana.
La nuova politica mondiale avviata dal giovane sovrano – da subito sbarazzandosi dell’ingombrante presenza di Bismarck – si concretizza in una serie di sfide lanciate sullo scenario internazionale: nei confronti della Russia, non rinnovando il trattato di controassicurazione, inserendosi nel “grande gioco” balcanico e appoggiando il Giappone nella guerra del 1905; nei confronti della Francia, con le visite al sultano di Damasco e Marocco ancora nel 1905; nei confronti della Gran Bretagna, solidarizzando con la rivolta dei boeri e soprattutto avviando il poderoso programma di costruzione di una flotta da guerra in grado di incrinare la supremazia britannica.
Lo spericolato imperialismo di Guglielmo II non può non mettere in allarme le altre potenze europee: il risultato è la vanificazione degli sforzi di Bismarck per evitare l’avvicinamento della Francia, Russia e Inghilterra. Nel 1911 nel porto di Agadir entra la cannoniera tedesca Panther, inviata dal governo di Berlino nelle acque marocchine come monito contro le pressioni francesi su quel paese. La crisi (che vede la mobilitazione della flotta inglese a sostegno degli interessi francesi) rientra: la Germania si accontenta di un pezzetto di Congo, lasciando mano libera ai francesi in Marocco. Ma l’episodio resta uno dei più significativi momenti di attrito che anticipano la guerra.
Sul piano interno l’età guglielmina segna per il Reich una stagione di intenso sviluppo industriale, favorito dal rigido protezionismo e caratterizzato dalla concentrazione delle imprese, con la formazione di importanti cartelli soprattutto nel settore del carbone e della metallurgia. La corsa agli armamenti risponde alle richieste dei quadri militari, reclutati prevalentemente tra gli Junker, i grandi proprietari terrieri che costituiscono la base del partito nazionalista e conservatore.
Se l’aristocrazia terriera a visto ridurre progressivamente il suo peso economico, di contro, attraverso la presenza nell’esercito, ha saputo accrescere il proprio valore politico. Con i cancellierati successivi a Bismarck (Caprivi, Hohenlohe, Bülow e dal 1909 Bethmann-Hollweg) i militari tedeschi fanno politica, consigliando l’emarginazione delle forze parlamentari estreme e suggellando la creazione di un blocco agrario-industriale. E tutto ciò nonostante un parlamento in cui è rappresentato il più forte partito socialista europeo.
Il fatto è che la socialdemocrazia tedesca, irretita nel gioco parlamentare fin dai tempi di Bismarck, ha abbandonato le posizioni rivoluzionarie mirando ad amministrare il relativo benessere della classe operaria tedesca. E quando nel 1912 conquista la maggioranza relativa in parlamento (34% dei voti), si impantana nel problema della collaborazione con i liberali e con il centro cattolico (Zentrum). Nel 1913 i militari chiedono un aumento della spesa al parlamento attraverso un’imposta diretta e i socialdemocratici cadono nella trappola: timorosi di perdere il treno del nazionalismo, contrari per formazione a qualunque imposta indiretta (che si ripercuote nella stessa misura su tutte le classi), essi votano i crediti all’esercito, segnando così la loro adesione alla politica di potenza.