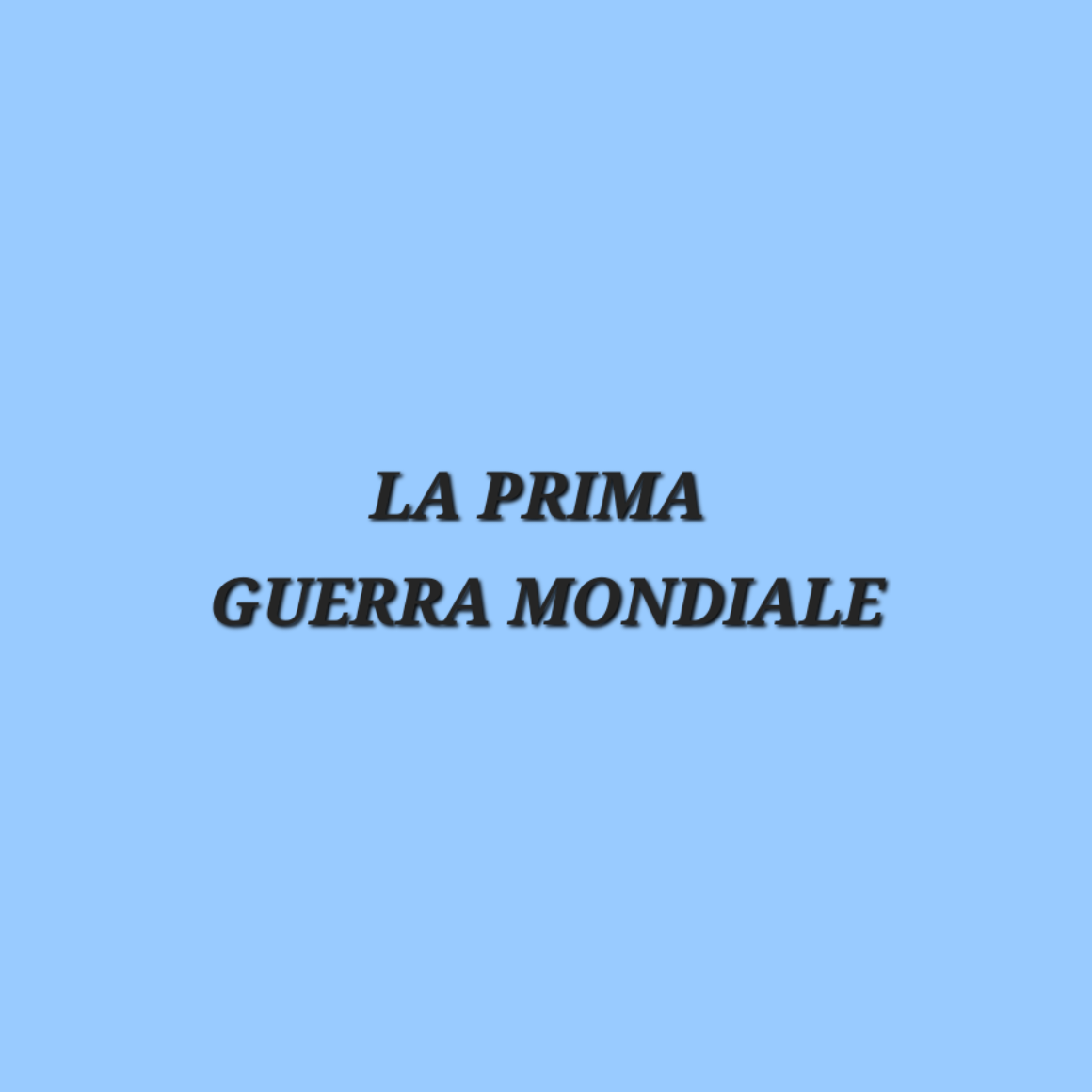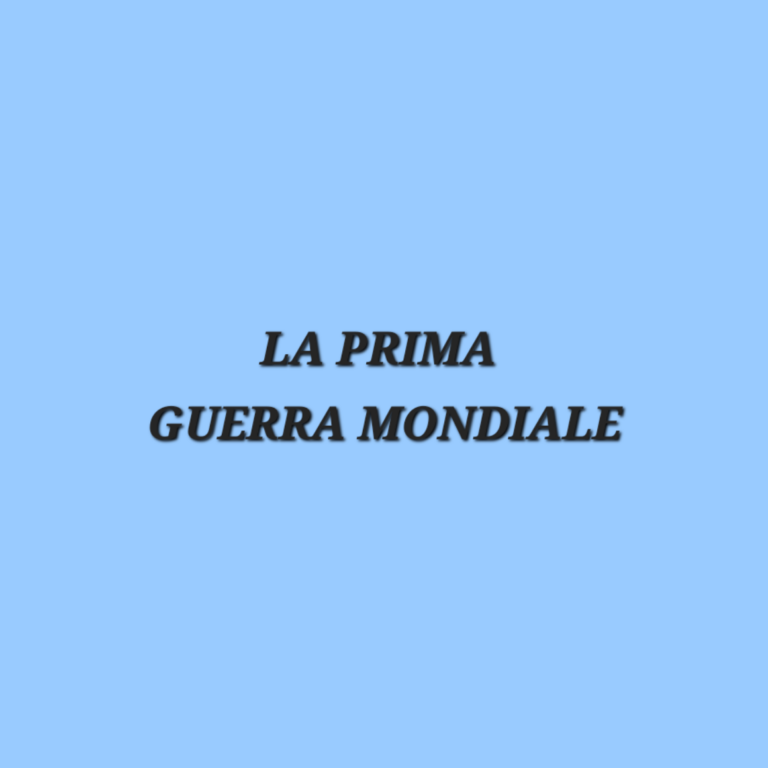PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE
Il grande ritorno della memoria sul XX secolo non si esaurisce con la seconda guerra mondiale, la shoah, le guerre di Corea e del Vietnam o anche d’Algeria. Il ritorno più importante, il più significativo, quanto meno in Francia, è quello della guerra del 1914-1918. L’aveva ben compreso nel 1995 François Furet in Le passé d’une illusion in cui, al di là della Rivoluzione francese del 1789 e della passione rivoluzionaria che ne nacque, mostra come la prima guerra mondiale abbia rappresentato la vibrazione essenziale, originaria, da cui deriva anche lo straordinario – per questo illusorio – successo dell’idea comunista del XX secolo. In tempi più recenti, in linea con gli studi e le riflessioni che hanno rinnovato la storia e l’immagine della Grande guerra, per impulso di Jena-Jacques Becker e della sua équipe di Scienze Politiche, all’Università di Paris X-Nanterre e al Centre de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre (Péronne, Somme), Stéphane Audouin-Rouzeau e Annette Becker hanno cercato di “ritrovare” questa guerra e di farla riscoprire ai nostri contemporanei che, pur non avendola vissuta, ne hanno avvertito spesso inconsciamente le ondate devastatrici per tutto il XX secolo.
La guerra del 1914-1918 ha rappresentato la disastrosa apertura di questo secolo tragico. Non solo a causa della terribile scia di morti e devastazioni che ha lasciato dietro di sé; non solo a causa delle ingiustizie, delle frustrazioni, dei germi di nuove guerre che, dopo l’insuccesso della pace di Versailles, essa ha lasciato in eredità agli europei e agli altri popoli – tutto questo si sapeva anche se la seconda guerra mondiale l’aveva nascosto abbastanza bene -; ma perché ha dato origine a una cultura del lutto, a una cultura della guerra, a una cultura dell’odio e della barbarie. La guerra del 1914-1918 ha prodotto e diffuso nel mondo gli orrori e le nevrosi distruttrici del XX secolo. Proprio essa – ed essa soltanto – è stata la Grande guerra.
Tutto questo è dimostrato in modo chiaro e sorprendente in questa storia della prima guerra mondiale, che esce al momento giusto. Alla sua funzione informativa ed esplicativa essa adempie anzitutto con un abbondante quanto sensato e ricco apparato illustrativo. Oggi è risaputo che le immagini sono un documento storico fondamentale, e che non si accontentano di illustrare quel che i testi dicono, ma sono il fermento stesso di quella componente della storia che si è imposta ormai in primo piano: l’immaginario storico. Le immagini che troviamo nei libri illustrati presentano anzitutto gli elementi reali: eventi, cerimonie, luoghi, protagonisti, sia sul piano individuale che su quello collettivo. Ben sintetizzate e valorizzate “finestre” sui capi politici e militari, e sulle battaglie, esse sono inserite in una narrazione in cui appaiono gli uomini, le folle, i contesti collettivi – a dimostrazione che la storia è fatta dei rapporti fra tutti questi elementi e che non è bene isolare se non per chiarezza espositiva.
Di più scopriamo che la guerra del 1914-1918 ha potuto beneficiare di una grande novità documentaria. È il primo grande evento storico “coperto” dalla fotografia. Ci sono immagini che hanno avuto un ruolo di primo piano nella Grande guerra: i manifesti – che mobilitano, al servizio della propaganda, la sensibilità collettiva a livelli mai raggiunti prima -, ma anche gli emblemi, le bandiere, le medaglie che hanno una loro parte importante nella simbologia in campo storico.
L’illustrazione non deve accontentarsi di riprodurre le realtà e i supporti concreti dell’immaginario: deve trovare i modi per mostrare la realtà facendone affiorare i significati nascosti e le conseguenze implicite. Di qui il numero e l’interesse delle tabelle, dei diagrammi e soprattutto delle carte. Non esistono buone pubblicazioni di storia prive di carte, perché la storia si fa nello spazio e sarebbe incompleta e astratta senza la geografia.
Non c’è fenomeno che più di una grande guerra esiga una maggiore considerazione dello spazio: ampi spazi di operazione, estesi dalla Manica ai Dardanelli, dall’Arabia all’Estremo oriente, dallo Jutland alle isole Falkland, sui mari e in tutti i continenti, giacché gli imperi coloniali dei paesi belligeranti furono forzatamente presenti sui campi di battaglia con i numerosi contingenti africani e asiatici, canadesi e australiani, per non parlare di quelli americani degli Stati Uniti.
Nei prossimi articoli troverete: i luoghi della guerra sul fronte e nelle retrovie, sulla terra, sul mare e nell’aria, nel cuore delle officine (l’economia, l’industria di guerra – il primo conflitto mondiale fu la prima guerra industriale – sono ben presenti) e in quel luogo mitico per i suoi angoscianti quanto concreti aspetti della socialità privata, che a quella guerra ha fornito una cornice dei suoi aspetti simbolici: la trincea, realtà materiale e psicologica intimamente legata alla storia e all’immagine della Grande guerra. Attraverso questi articoli assisterete alla terribile e sconfortante avventura secondo la formula tradizionale: “come se ci foste”. Scoprirete anche le armi utilizzate, in particolare quelle che hanno segnato una forte novità, anche in questo caso tecnologica e simbolica insieme: il carro armato, il dirigibile, la corazzata, i mezzi d’assalto e soprattutto i due grandi protagonisti che nel 1914-1918 fanno un clamoroso ingresso nella storia, l’aereo e il sottomarino.
Guerra di uomini, il primo conflitto mondiale coinvolse in modo altrettanto profondo donne e bambini, molto presenti in questi articoli. Altrettanto presenti sono la religione attraverso il Vaticano, il clero, le cerimonie religiose, i sentimenti e le esperienze degli uomini, la letteratura e l’arte attraverso gli artisti combattenti – e, più di uno di essi, vittime – e le opere, rarissime in pittura, che la guerra ha ispirato. Per finire, è ricordata l’immagine della guerra al cinema, da Charlie Chaplin a Bertrand Tavernier, passando attraverso la cinepresa critica di Stanley Kubrick, il cui film Sentieri di gloria è stato a lungo vietato dalla censura francese. L’espressione della memoria simbolica della guerra è coronata, per così dire, dall’irruzione del lutto nei paesaggi urbani e rurali, la fioritura dei cimiteri e dei monumenti ai caduti.
Naturalmente non si può riassumere in questa presentazione il contenuto di tutti gli articoli che seguiranno. Si tratta di una narrazione degli eventi con l’attenzione necessaria e precisa alla cronologia e con una pertinente successione di periodi ben caratterizzati con le loro febbri e i loro ristagni, le loro illusioni e le loro delusioni, e l’affrettata conclusione che tutti conosciamo.
All’inizio abbiamo ricordato che la Grande guerra è stata iniziatrice di una cultura dell’odio e della barbarie. È un aspetto ben presente i questi articoli. Il grande storico Marc Bloch, che combatté strenuamente nella Grande guerra e morì da partigiano, fucilato dai tedeschi nel 1944, aveva trovato e studiato un elemento originale e significativo di questa cultura di guerra: la produzione e la diffusione di false notizie. Negli articoli troveremo ricordato un fenomeno sussidiario di questo stato d’animo: lo spionaggio – soprattutto attraverso il contestato e mitizzato personaggio di Mata Hari. Ma penso soprattutto a tutti i corpi feriti, mutilati, morti o agonizzanti, disseminati in questa storia di una guerra a proposito della quale si è potuto scrivere: “la storia della guerra è anzitutto la storia del corpo”.
Infine, gli storici sanno che un evento, per quanto grande possa essere (e forse in misura proporzionale alla sua grandezza), non nasce né muore di colpo: viene da lontano e si prolunga nel tempo. Pur trattandosi di “un evento storico senza precedenti”, la Grande guerra è venuta da lontano e ha proiettato davanti a sé “un’ombra lunga”.
Storia di un evento totale, questi articoli sono articoli di storia totale. Per quelli che vogliono “ritrovare” la Grande guerra che illumina – tragicamente – il nostro presente, questi articoli saranno una guida indispensabile.