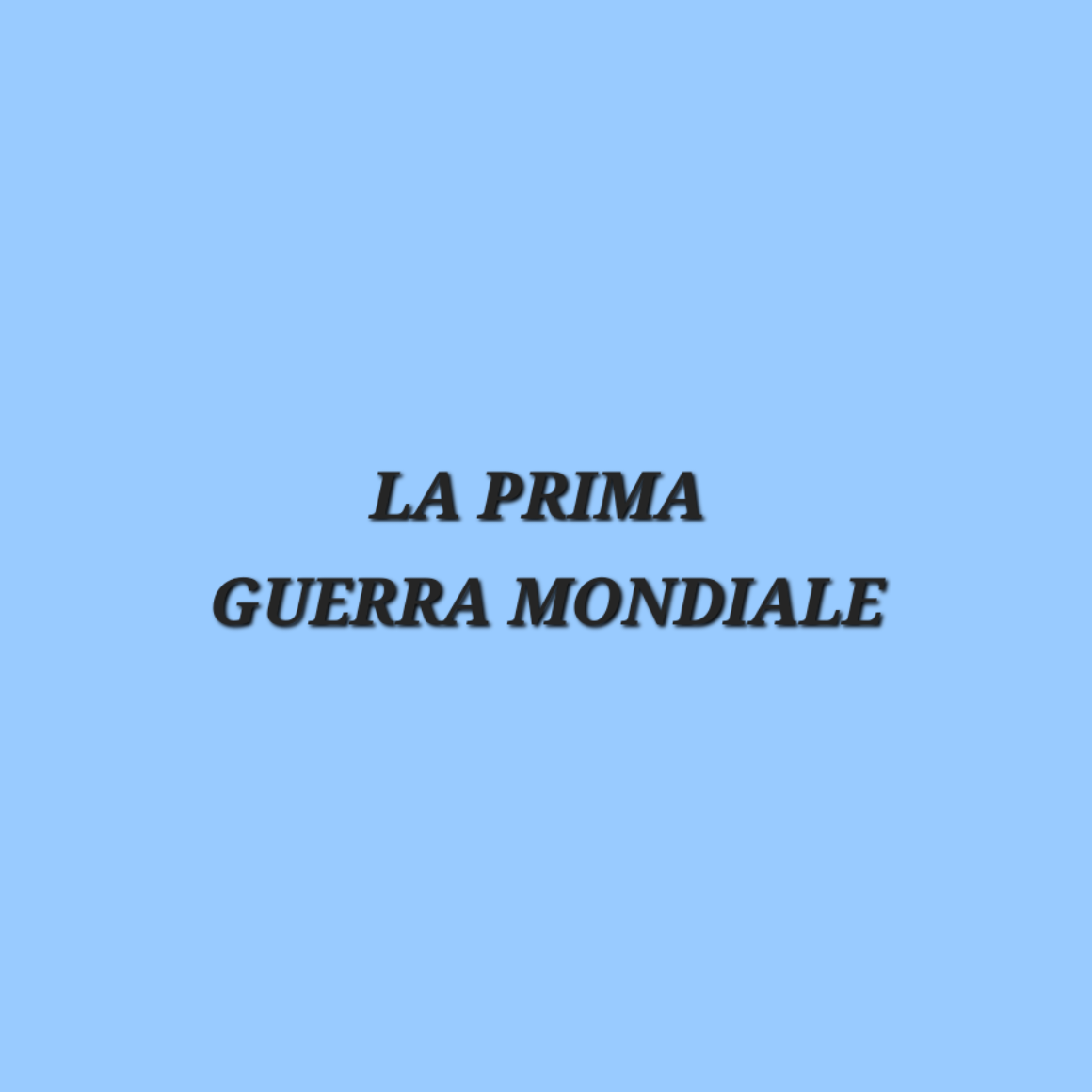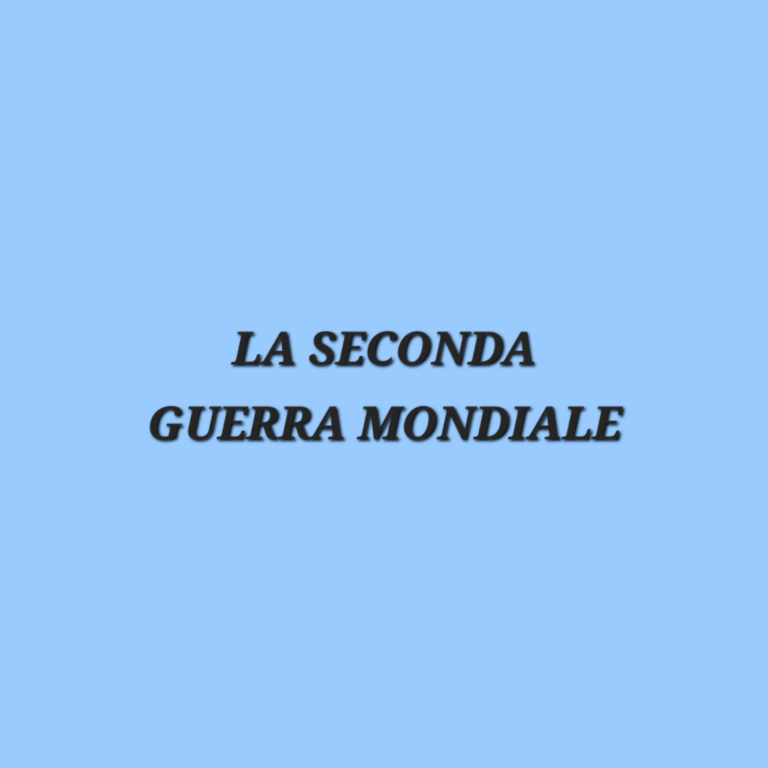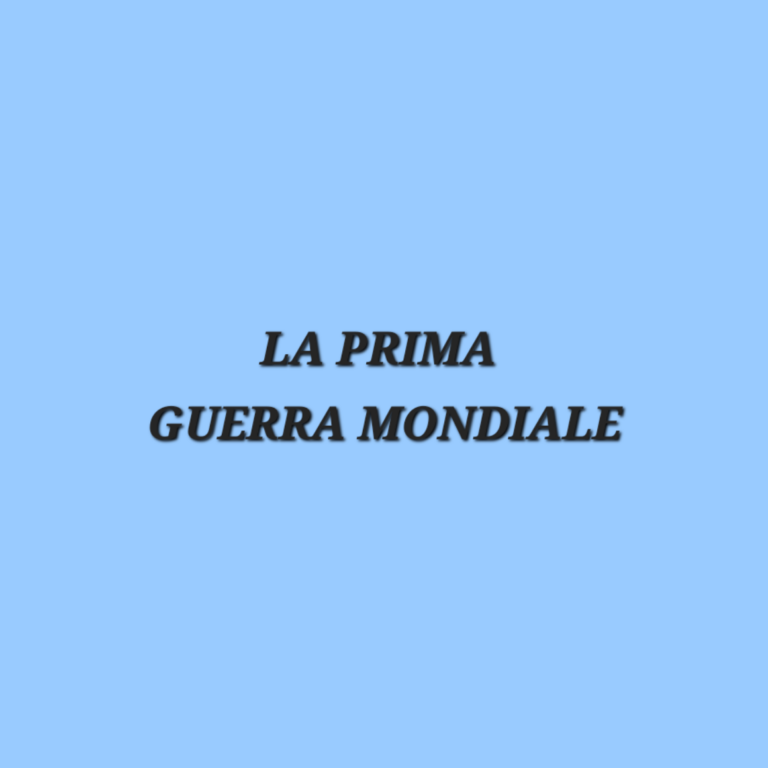LA QUESTIONE BALCANICA
LA QUESTIONE BALCANICA
Quando l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando innesca il conflitto mondiale, la tensione nei Balcani è a un punto di rottura. Ma è da ormai un secolo che la questione balcanica costituisce un fattore di destabilizzazione e di attrito internazionale. Mosaico di etnie, culture e fedi religiose, obiettivo delle mire espansionistiche delle potenze europee, i Balcani subiscono con la crisi dell’Impero ottomano un travagliato processo di frammentazione politica. A minare le strutture dell’Impero nell’area sono in primo luogo le rivendicazioni nazionali delle varie popolazioni.
Nel corso dell’Ottocento le tendenze nazionali delle province di stirpe greca, slava, bulgara e rumena si sono andate accentuando e si è assistito a susseguirsi di insurrezioni locali. Se la Grecia si è staccata dall’Impero già nella prima metà del secolo, Romania, Serbia e Montenegro ottengono l’indipendenza con il congresso di Berlino nel 1878; nella stessa occasione la Bulgaria si costituisce in principato autonomo per poi proclamarsi regno indipendente nel 1908. Ma il difficile equilibrio costituito dalla diplomazia a Berlino è destinato a crollare, travolto dalla spinta espansionistica delle nuove entità statali e dalla corsa delle potenze europee a guadagnarsi la propria parte nella spartizione dell’Impero ottomano.
Nel 1903 in Serbia l’associazione segreta Mano nera (Crna Ruka), composta prevalentemente di ufficiali nazionalisti, appare all’improvviso sulla scena politica con l’assassinio del re Alessandro Obrenoviće della regina Draga, accusati di condurre una politica filoaustriaca. Sul trono viene messo l’esule Pietro Karagjeorgjevic: da allora il giovane Stato serbo si fa leader dell’irredentismo slavo, ergendosi in funzione antiaustriaca e sostenendo la causa della libertà della Bosnia. Il re Pietro I e il suo primo ministro Nikola Pašić, fautori di un aspro nazionalismo, non disdegnano di fomentare l’attività delle organizzazioni terroriste nei Balcani.
Mentre cresce l’attrito tra la Serbia e l’Impero austroungarico, la Russia si fa portabandiera della difesa delle popolazioni slave ortodosse. Nel 1912 Serbia, Bulgaria, Grecia e Montenegro, sostenute dalla Russia, attaccano e sconfiggono la Turchia. La pace di Londra sancisce la creazione del principato di Albania (con cui l’Austria-Ungheria riesce a impedire che la Serbia ottenga lo sbocco al mare), ma lascia sul campo ostilità irrisolte, che già nel 1913 sfociano in un nuovo conflitto.
La seconda guerra balcanica vede la Bulgaria contrapposta a una coalizione che raccoglie Serbia, Grecia, Montenegro, Romania e Turchia. Sconfitta la Bulgaria, la pace di Bucarest stabilisce un nuovo assetto territoriale, che non seda i rancori né soddisfa le aspirazioni nazionaliste. Lo scontro ha prefigurato gli schieramenti che si ricreeranno nella guerra mondiale: le due sconfitte, Turchia e Bulgaria, dalla parte degli Imperi centrali, la Serbia e la Romania a fianco dell’Intesa. La situazione dei Balcani resta esplosiva.