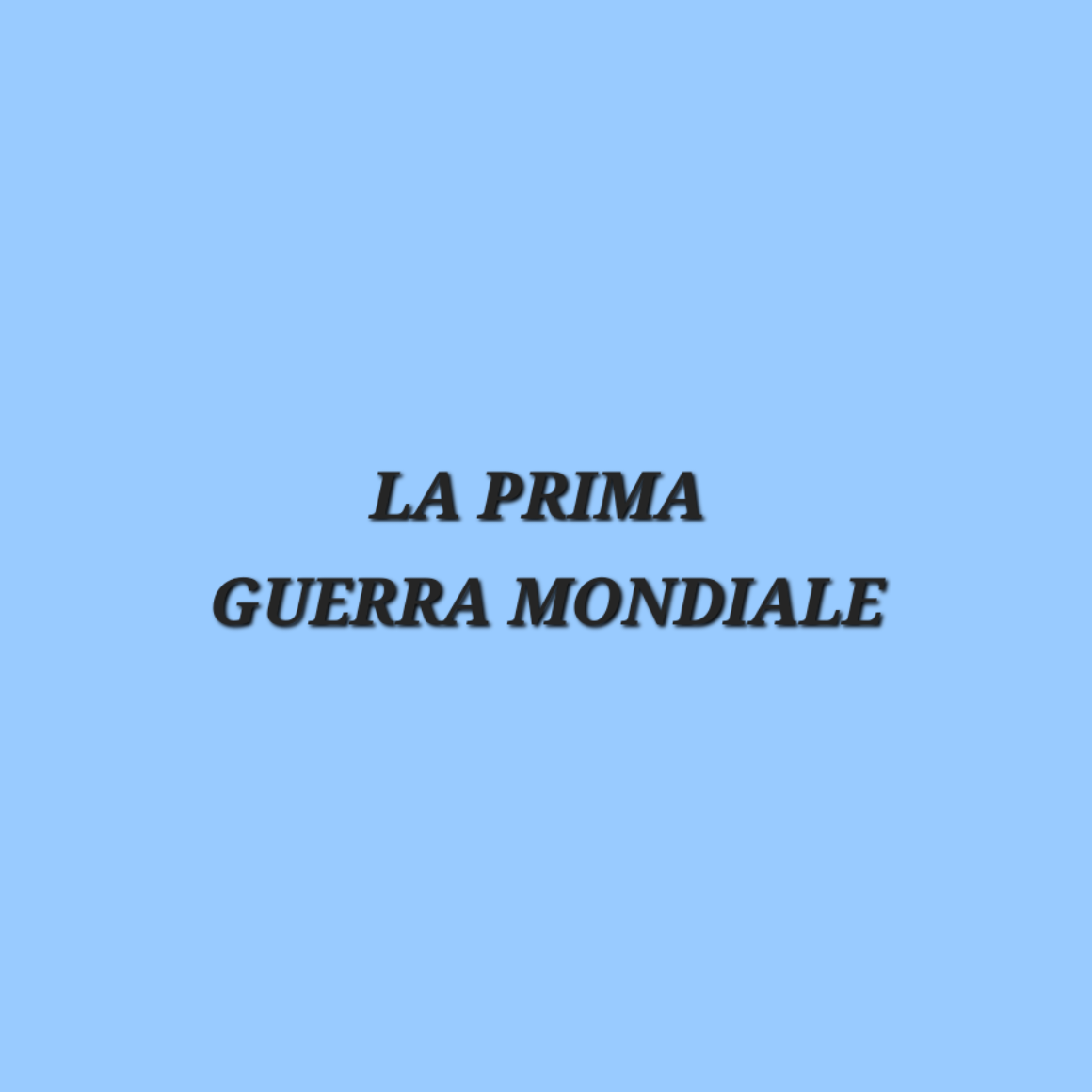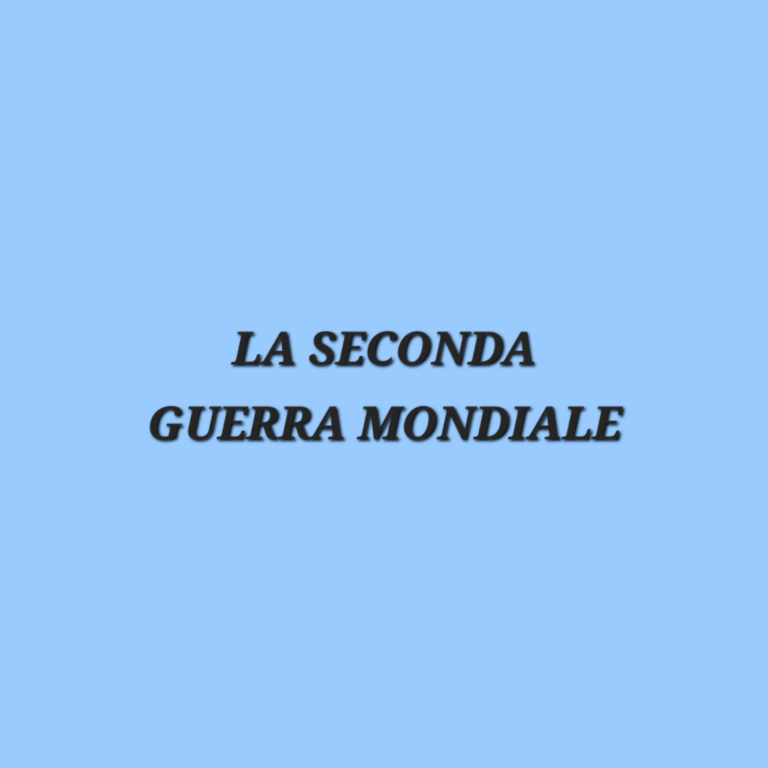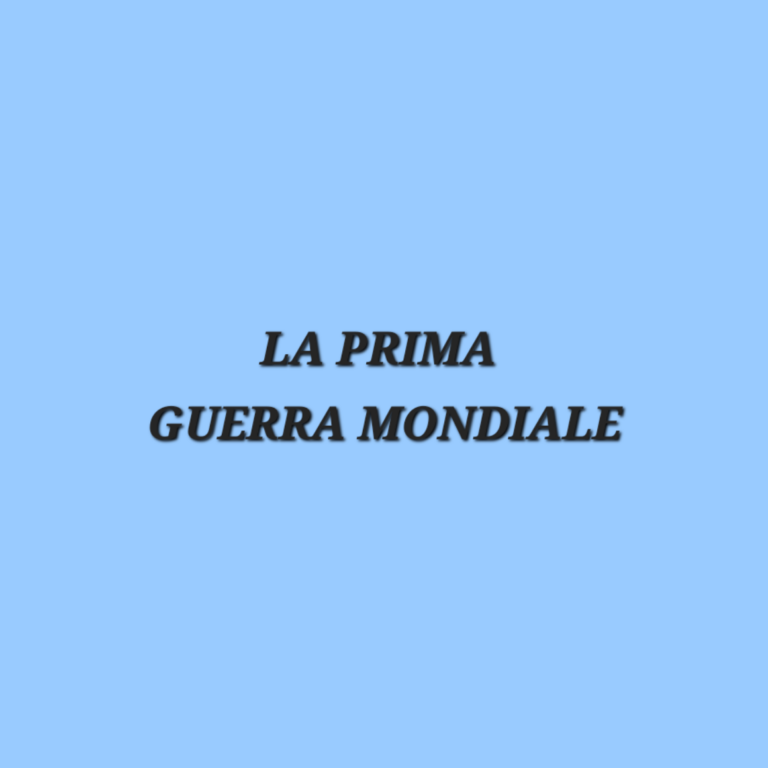L’EREDITÀ DELLA REGINA VITTORIA
L’EREDITÀ DELLA REGINA VITTORIA
Nel corso di tutto l’Ottocento la Gran Bretagna, uscita vincitrice dai conflitti napoleonici e forte di una posizione di predominio economico e militare, conduce una politica di equilibrio sul continente, volta a impedire l’affermazione di una potenza sulle altre. Nei rapporti internazionali propende a mantenere le distanze da un eccessivo coinvolgimento nelle questioni europee per concentrare il massimo impegno sul fronte coloniale.
La seconda parte del lungo regno della regina Vittoria (1837-1901) segna in effetti l’apogeo della potenza imperiale britannica. Sotto la guida del conservatore Benjamin Disraeli, massimo fautore della politica imperialista, il governo assume sotto il proprio controllo diretto i possedimenti della Compagnia delle Indie e la regina è proclamata imperatrice dell’India (1876). In Africa le guerre contro dervisci e zulù concretizzano il sogno di un dominio ininterrotto fra l’Egitto e il Capo; il controllo del canale di Suez, con Malta e Gibilterra, significa per Londra il dominio della rotta per le indie attraverso il Mediterraneo e il Mar Rosso. Presso l’opinione pubblica questo aggressivo dinamismo politico-militare è sostenuto da un vasto movimento culturale che lega all’espansione coloniale il concetto di “fardello dell’uomo bianco”, secondo la definizione dello scrittore Rudyard Kipling, cioè l’idea di una universale missione civilizzatrice cui il popolo inglese sarebbe chiamato.
L’intensa politica imperialista è tuttavia per la Gran Bretagna anche il terreno in cui vengono messe a nudo le sue debolezze e si originano le tensioni con i concorrenti europei. Con l’incidente di Fashoda (1898) si sfiora in Africa il conflitto con la Francia, costretta a rinunciare all’espansione nel Sudan e verso il Mar Rosso. Poi, la guerra per piegare la piccola repubblica boera del presidente Paulus Kruger (1899-1902) guadagna alla corona il dominio su tutto il Sudafrica ma, troppo lunga e teatro di estreme atrocità, dimostra che l’esercito britannico ha bisogno di essere riorganizzato e soprattutto rivela l’isolamento politico internazionale in cui ha finito per trovarsi il paese.
Se i rapporti con la Russia non sono esenti da attriti per la pressione di San Pietroburgo sui Dardanelli e sull’Afghanistan, è con la Germania che negli anni precedenti al 1914 si va creando il contrasto più insanabile. La Gran Bretagna è costretta infatti ad assistere con crescente preoccupazione all’espansione commerciale tedesca, soprattutto dopo l’esperienza della crisi economica di fine Ottocento (Great Depression), che ha esasperato i conflitti sociali interni e che, nel caso specifico, è in parte imputabile alla concorrenza mossa ai prodotti britannici da parte di quelli dei paesi emergenti.
In un primo tempo Londra cerca di far fronte alla situazione cercando un avvicinamento con la Germania stessa e fra il 1898 e il 1901 il ministro delle colonie Joseph Chamberlain progetta perfino un’alleanza con il Reich. Ma tutti i tentativi di accordo falliscono, mentre crescono i motivi di attrito tra le due potenze: dalla concorrenza nella corsa agli armamenti navali alla crescente penetrazione militare ed economica della Germania nell’Impero ottomano. Londra è dunque costretta ad abbandonare il suo “splendido isolamento” e ad arrivare una nuova politica di alleanze continentali. Dapprima si giunge all’informale patto con la Francia del 1904 (Entente cordiale), con il quale si sancisce il reciproco riconoscimento dei possedimenti africani. Dopo che si è pervenuti ad un accordo anche con la Russia, in merito ai rispettivi interessi in Persia, nel 1907 con la Triplice intesa i tre paesi stringono un’alleanza in funzione antitedesca e antiaustriaca.
La lezione della guerra sudafricana porta la Gran Bretagna anche a rivedere la politica nelle colonie, avviando alcuni esperimenti di autogoverno: fra il 1901 e il 1910 lo status di “dominion” viene esteso all’Australia (1901), alla Nuova Zelanda (1907) e all’Unione Sudafricana (1910). Resta aperta tuttavia la grave questione irlandese. L’isola è stata occupata nel XVII secolo, ma da allora le due comunità, quella indigena e cattolica e quella formata dai coloni britannici protestanti, sono rimaste divise e fra loro ostili. Nell’Ottocento si sono sviluppati movimenti separatisti, a partire dal 1906 si intensificano le agitazioni nazionaliste, mentre fallisce il tentativo di porre in vigore un progetto di legge di autogoverno (Home Rule), che non piace agli estremisti protestanti, ai conservatori e all’esercito, ma non soddisfa nemmeno le speranze del Sinn Fein, il partito nazionalista irlandese.
Sul fronte interno, la Gran Bretagna è, negli anni che precedono la guerra, teatro di grandi fermenti sociali. Dopo le riforme elettorali delle ultime decadi dell’Ottocento, che hanno reso il voto maschile quasi universale, importanti conquiste si hanno nel campo della difesa dei sindacati, delle assicurazioni per i lavoratori e delle pensioni sotto il governo del liberale Asquith (1908-1916). Nonostante ciò, il confronto sociale è aspro: nel 1906 nasce il partito laburista che raccoglie le forze operaie e tra il 1910 e il 1912 una serie di scioperi scuote il paese; nel 1911 il peso politico dell’aristocrazia è ridimensionato dal Parliament Act che abolisce il diritto di veto della Camera dei Lord; il movimento delle suffragette è sempre più attivo nella lotta per il voto alle donne, mentre la corona, con re Giorgio V (1910-1936), si assume un ruolo di mediazione tra le varie componenti della collettività.