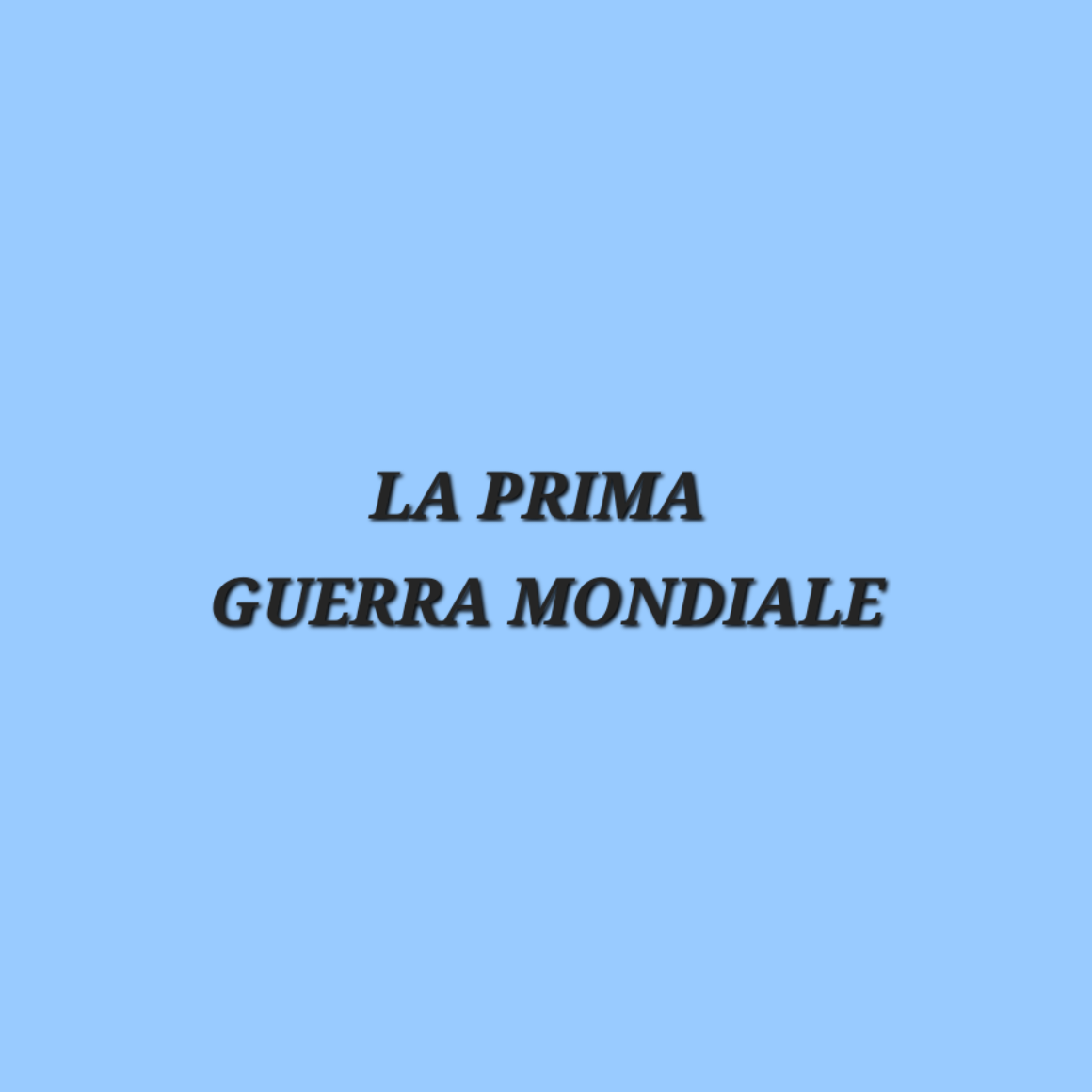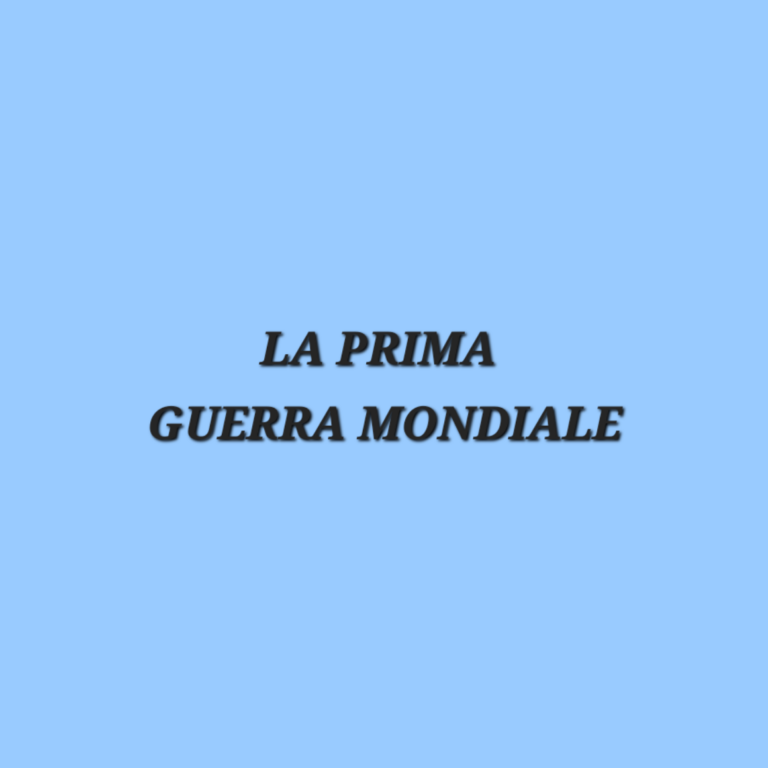IL LUNGO REGNO DI FRANCESCO GIUSEPPE
IL LUNGO REGNO DI FRANCESCO GIUSEPPE
Durante la prima parte del lungo regno di Francesco Giuseppe, le sconfitte subite dall’Austria ad opera della Francia prima (1859) e della Prussia poi (1866), hanno di fatto spento ogni speranza di egemonia degli Asburgo sui territori di lingua tedesca e posto fine alla loro influenza sull’Italia. Il centro di gravità dell’Impero si è spostato a oriente, rendendo sempre più pressanti le questioni poste dalla difficile convivenza in un’unica entità politica di popolazioni, etnie e culture diverse, il cui crescente nazionalismo, primo tra tutti quello magiaro, minaccia in maniera sempre più allarmante le strutture stesse dello Stato. Nel 1867 Francesco Giuseppe, nel tentativo di imprimere una riforma allo Stato, si risolve a optare per un compromesso (Ausgleich) e concede all’Ungheria l’indipendenza e un parlamento bicamerale. L’unione con l’Austria si mantiene nella persona del sovrano, che assume su di sé i titoli di imperatore d’Austria e di re di Ungheria. Si sancisce in questo modo il predominio dell’elemento magiaro, accanto a quello austro-tedesco, sugli altri gruppi etnici, in particolare gli slavi, che costituiscono la popolazione più numerosa tra quelle che abitano l’Impero.
La soluzione che dà vita al dominio bipartito degli Asburgo non può tuttavia sanare gli squilibri economici tra le regioni occidentali, che vedono la formazione di un proletariato urbano organizzato dai movimenti socialisti, e quelle orientali, agricole e più soggette alle crisi economiche e dove la struttura sociale si fonda su un’aristocrazia terriera priva di qualunque dinamismo e incapace di aprirsi all’ammodernamento.
Tale soluzione non risolve neppure, anzi semmai acuisce, i problemi di un Impero multietnico nell’era dei nazionalismi, suscitando il risentimento delle componenti escluse dal compromesso (cechi, slovacchi, croati), che puntano a un ordinamento compiutamente federale, e di quelle minoranze (italiani e serbi) più chiaramente irredentiste. Tutto questo mentre fra i sudditi di lingua tedesca vanno crescendo sentimenti e idee di stampo pangermanistico e di conseguenza filotedesche.
Lo scontro delle nazionalità si riverbera nel parlamento di Vienna, paralizzando lo svolgimento della vita politica. Nel 1907 l’introduzione del suffragio universale maschile dà al parlamento austriaco una maggioranza dell’elemento slavo, a sua volta tuttavia troppo diviso per poter esprimere una politica di governo unanime: dal 1909 il paese è amministrato attraverso ordinanze imperiali. Sul versante ungherese intanto l’egemonia magiara si traduce progressivamente in una vera e propria persecuzione delle minoranze etniche.
In politica estera, a partire dal congresso di Berlino che nel 1878 le affida l’amministrazione della Bosnia-Erzegovina (provincia turca abitata prevalentemente da popolazione serba), l’Austria-Ungheria appare sempre più coinvolta nei Balcani. Se da un lato tale tendenza è conseguenza della perdita di potere in Italia e in Germania, dall’altro essa è indice della progressiva subordinazione della politica estera di Vienna alle esigenze di Berlino, cui nel 1882 l’Impero asburgico si lega insieme all’Italia nella Triplice alleanza.
Fino ai primi del Novecento la penetrazione nei Balcani è essenzialmente economica. Nel 1908, in contemporanea con la rivoluzione dei Giovani turchi all’interno dell’Impero ottomano, si giunge però all’annessione della Bosnia-Erzegovina: dietro alla decisione ci sono le speranze di rivincita dei militari austriaci, ma anche la diplomazia di Berlino che intende intralciare i progetti russi di penetrazione nei Balcani. La mossa inasprisce i rapporti tra slavi e tedeschi all’interno dell’Impero, mentre all’esterno riesce a urtare contemporaneamente i serbi, lo zar (che si proclama difensore degli slavi ortodossi nei Balcani), e l’Italia (che non vede di buon occhio la politica adriatica di Vienna).
Ad ergersi in funzione anti-austriaca è soprattutto la Serbia, dove prendono piede movimenti irredentisti che mirano a liberare le popolazioni slave della Bosnia. Dalle guerre balcaniche degli anni 1912-1913 la Serbia esce militarmente rafforzata, ma al tavolo della pace l’Austria-Ungheria ottiene che, con la creazione dell’Albania, l’ostile vicino si veda sottrarre lo sbocco al Mare Adriatico conquistato durante il conflitto. I rapporti tra i due paesi si fanno sempre più aspri: l’impennata del sentimento nazionale in Serbia rafforza l’impressione che il confronto diretto fra Belgrado e Vienna non sia più rimandabile.